Elogio delle ore (Amami)
+20
Hellionor
Resdei
Arianna 2016
Nellone
Arunachala
Asbottino
Byron.RN
mirella
FedericoChiesa
CharAznable
Molli Redigano
Susanna
Petunia
ImaGiraffe
digitoergosum
gipoviani
tommybe
paluca66
Antonio Borghesi
Different Staff
24 partecipanti
Different Tales :: Off Topic :: Archivio :: Different Rooms - Tutti i racconti :: Step 13 - L'autorimessa
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2 • 1, 2 
 Elogio delle ore (Amami)
Elogio delle ore (Amami)
Ora io ti guardo, ora tu mi guardi.
Ora siamo qui, ora e ancora, così.
Ore, le ore.
Le ho contate ogni settimana per rivederti, fino a quell’ora, quel giorno, ogni settimana, ogni volta come fosse l’ultima possibile.
Le ore.
Due soltanto, due, per scambiare poche parole in una palestra poco frequentata, mezzo saluto, un’occhiata indifferente.
Ore che volano, passano, ore, la settimana intera e poi ancora.
Per rivederti, due ore di più, ancora due, e se non c’eri, ore perdute, fino alla prossima, le prossime due.
Ora siamo qui, senza che le ore abbiano più significato.
Perché t’ho trovata quell’ora, quel giorno, persa come me.
Ora ti ringrazio per essere nata.
Per essere te.
Prima di morire, conoscere l’amore.
Prima dell’inverno, conoscere l’amore.
Avevo in mente quella canzone, quando è iniziato tutto. Era l’ultima che suonava sulla playlist nell’USB della macchina.
Quella canzone lì.
“Quante ne sono passate?”
“Di giornate?”
“Di ore.”
Non lo so. Ho smesso di contarle, già da parecchio.
Continuiamo a guardare la porta basculante chiusa: noi siamo dentro, loro sono fuori.
Tre mura di cemento dall’intonaco scrostato e una porta basculante chiusa, la Honda parcheggiata nel mezzo, una lampadina pendente: tutto uno spettacolo migliore delle nostre facce stanche, perse, arrabbiate.
Abbiamo percorso ogni centimetro percorribile di questo spazio angusto. Ci siamo seduti in auto e poi alzati. Davanti, dietro, aperto e chiuso portiere. Abbiamo guardato da sotto il battente sperando che loro se ne andassero, ma loro sono sempre lì, barcollanti, assenti, infaticabili.
“È colpa tua.” Lo dici e lo ridici, come cambiasse la realtà delle cose. “È tutta colpa tua.”
“Certo.” La pandemia, il caos, le combinazioni di eventi, gli incontri casuali, le scelte fatte in un momento. Colpa mia.
“Dovevo arrivare alla mia macchina.” Lo stesso tono spezzato, sempre uguale. “Potevo farcela.”
“E dillo ancora, tanto ormai.”
I passi strascicati degli infetti, fuori dalla porta, nel locale dei garage.
Scuoti la testa e quegli occhi chiarissimi che ti ritrovi. “Sei proprio uno stronzo.”
“Certo.”
Sono ore, forse giorni, che voglio dirtelo, dirti tutto, dalla prima all’ultima lettera, e ogni volta penso che non è ancora il momento. Che ne verrà uno migliore. Che ci troveranno e ci porteranno via da qui, e che non meriti di sapere tutto quanto, tutta la storia.
Vaghiamo tra quattro mura, sei metri per tre, con un’auto nel mezzo e una lampadina che pende dal soffitto. Se si brucia, neanche più quella.
“Dovevo arrivare alla mia macchina.” Singulto e viso arrossato. “Potevo farcela.”
Erano cento metri. Non potevi farcela. T’avrebbero presa prima, morsicata, fatta a pezzi. E pure me, perché sarei venuto a prenderti, difenderti, proteggerti, anche se non te lo meriti.
Non ti meriti il mio sacrificio.
Non ti meriti che ti abbia trascinata dentro il passo carraio, nel locale garage, dentro il mio, che era aperto, perché stavo uscendo. Dovevo lasciarti in strada.
“Sei proprio uno stronzo.”
Lo sono. Verso me stesso: mi sono sempre trattato male. Sempre fatto del male. Con te e quelle come te.
“Dovevi proprio uscire stasera?” Ammesso che sia ancora sera, che sia ancora oggi. Le ore passano e non abbiamo nulla per contarle.
“Ma che cazzo vuoi, è sabato!”
“E dovevi proprio venire al Jamaika.”
“Sì, infatti.”
Cento metri da casa mia, uno stupido pub, sabato sera. E io stupido che ho pensato d’uscire, anziché stare a casa a giocare alla Play Station. Magari t’incontravo. Per caso, come è già successo, qui intorno, o in altri posti meno logici. Per un saluto accennato, indifferente.
Magari t’incontravo.
E ti ho incontrata, nel mezzo dell’apocalisse. Il caso, a volte. Chiudersi in garage, aspettare che gli infetti vadano via; ma non se ne sono andati, sono rimasti lì fuori, nel passaggio buio, a trascinarsi e mormorare.
Sono ancora lì, da ore e ore. Forse di più.
Non se ne andranno mai.
“E hai pure perso il telefono!” Lo dici con quella nota stridula che sono unghie sulla lavagna. La tua voce è tutto un fastidio viscerale.
“E le chiavi della macchina.”
“E bravo, a posto così.”
Le ho perse per portarti via dalla strada e dal caos, sgomitando con gli infetti. “Potevo lasciarti lì.”
“E dovevi, cazzo!”
Scuoto la testa.
“E adesso moriremo qui.”
Possibile. Probabile, per mera statistica.
Sbatti le mani sui tuoi pantaloni leggeri color vinaccia e le porti al viso. Singhiozzi.
Volevo salvarti, non lo dico.
Vorrei dirlo, da ore. Un sacco di ore.
Vorrei dirti anche il resto.
“Cazzo, che eroe che sei!”
Eroe, le ore.
“Dacci un taglio. Anche basta.”
“Dovevi lasciarmi arrivare alla macchina, ce l’avrei fatta!”
Volevo salvarti, non lo dico.
“E adesso devo morire qui dentro.”
“Volevo salvarti,” l’ho detto.
Mi guardi con tutto quell’astio che hai sempre avuto, che non ho mai capito. “Ma se praticamente neanche ti conosco.”
“Vero.”
“Non potevi farti i cazzi tuoi, no?!”
“Non potevo.” Non dopo averti trovata così, in strada, con dietro gli infetti e il mondo che di colpo non aveva più una direzione.
“Perché?!”
Perché mi hai sempre fatto uno strano effetto, non lo dico.
“Perché provo qualcosa per te,” l’ho detto.
Resti in silenzio e con gli occhi dilatati, ma non è sorpresa, è banale indignazione. Ho sempre quella canzone in testa.
Sbatti i palmi e agiti appena le mani, come di fronte alle cose patetiche della vita, con quel sorriso tanto amabile quanto odioso. “Siamo alla pazzia.”
La pazzia è qui dentro e non là fuori, con le folle di malati, il panico e la distruzione, la fine dei giorni. Le ore che passano.
“È la verità.”
“Oh,” il tono è compassionevole solo per la prima sillaba, poi diventa acre, “ma guarda che lo sapevo.”
“Certo.”
“Lo sapevo, invece. Stavi sempre a guardarmi, in palestra.”
“Certo. È come mi guardi tu, il problema.”
“Come ti guardo io?”
“Come adesso: con tutto ‘sto astio, ‘sto fastidio.”
“E ci mancherebbe pure!”
Due ore, quelle due ore di martedì per incontrarti in palestra, non lo dico. “Pensa che volevo venire pure di giovedì, perché sapevo che c’eri tu. Ma non riuscivo con gli orari.”
“E meno male.”
“Posso dirtelo?”
Alzi di spalle. “Tanto ormai.”
“Sì, ormai.”
Prendo un respiro per il momento che ho atteso da così tanto tempo.
“Sei,” la scelta di termini più difficile, “sei un dito in culo. Sei la ragazza più irritante del mondo. Non so come si faccia a stare con te più di dieci minuti. Se ho ancora sanità mentale dopo tutte queste ore è perché ho il principio inchiodato nella testa di sopportare tutto e tutti, ma tu vai oltre ogni mio limite. Sei la somma dei peggiori difetti che una donna può avere, a parte essere figa, e io non so neanche da dove iniziare a elencarli.”
Silenzio.
Hai le iridi che sembrano lune e le labbra piegate all’ingiù. “Hai finito?” Lo dici con la voce che oscilla.
“Ho finito.” Non un grammo d’aria nei polmoni e sempre quella canzone in testa.
Scende un silenzio atroce. Ora io ti guardo, ora tu mi guardi.
Scoppi a piangere senza un suono e con le mani a coprire metà del viso. Gli infetti, fuori dalla porta, si lamentano come a farti il verso.
“E che cazzo, qualcuno doveva dirtelo prima o poi, oh.”
Persino i tuoi singulti sono una tortura cinese.
Passano minuti che sembrano ore.
Ce ne vorrebbero molte altre, di ore, per dimenticare tutto questo.
Sospiro. “Ehi.” Fai segno di no, di lasciar stare. Se riesci a farmi sentire in colpa è solo perché ho un animo gentile. “Dai, sfogati tu. Di’ quello che pensi, di me, di tutto. Vai.”
Ti levi le lacrime a ditate nervose. “Mi sei sempre stato sul culo, sempre.”
“Lo so. Ma non so il perché.”
“Perché ti dai un sacco di arie, ti credi chissà chi.”
“Io?”
“Invece sei stupido e insulso.”
“Vai.”
“Non sei simpatico, non fai ridere, non c’è niente di te che sia interessante, nulla. Sei come un buco nero che assorbe la luce degli altri.”
“Questa l’hai preparata, si sente.”
“Ma io dovevo essere salvata proprio da te?!”
“Io in te dovevo imbattermi quando sono uscito in strada a vedere che stava capitando?!”
Restiamo così, soli al mondo, tra quattro mura scrostate, con un’auto in mezzo che non posso mettere in moto. Ci vuole un po’ per guardarti alzare di nuovo lo sguardo, per la prima volta carico di una qualche sensazione che non intendo.
“Mi stavi seguendo, vero?”
“Certo che no.”
“Sì, invece. Ne sei capace, te lo si legge in faccia. Hai una faccia da psicopatico.”
L’ho fatto, una volta, seguirti. Volevo capire dove abiti, per incontrarti più facilmente per caso, un giorno: non lo dico.
“Pensavo avessi finito.”
“Ammetti che mi stavi seguendo.”
“L’ho fatto una volta,” l’ho detto, “ma ti ho persa al primo semaforo. Come segugio faccio schifo.”
“Lo sapevo! Psicopatico!”
“Piantala. Io abito qui. Questa è casa mia, anzi è il mio garage. Sei TU che sei andata al Jamaika, che hai parcheggiato qui davanti. È colpa tua.”
“Sì, certo.”
“Sono sceso giù perché volevo prendere la macchina e andare a fare un giro in notturna. Poi ho sentito le urla, il caos, sono uscito in strada. E ho visto te.”
“Sì, certo.”
“Quando ero lì, quando ho capito che era l’apocalisse, sai cosa ho pensato?”
“Non lo voglio sapere.”
Che c’era una sola persona che desideravo stesse bene, ed eri tu: non lo dico.
“Che se t’incontro in versione infetta non lo so se ho il coraggio di abbatterti.” L’ho detto.
Hai la faccia grave come un lutto. “Tu sei del tutto pazzo.”
“Volevo salvarti, non ho pensato ad altro.”
“Non hai pensato, appunto. Adesso siamo chiusi qui, senza un telefono, senza le chiavi dell’auto. Senza niente da mangiare, da bere, con quei mostri lì fuori.”
“Arriveranno i soccorsi.”
“E se non arrivano?”
Non ho una risposta. Chiudi ogni contatto aprendo la portiera del passeggero, salendo in macchina e isolandoti dal resto del mondo, che sono soltanto io.
Ci metto minuti per aprire quella del guidatore e salire a mia volta.
“Aspetta,” ammonisco quando stai già per scendere, “ho esagerato, d’accordo? È una situazione estrema e siamo sotto pressione.”
“Io non ho esagerato niente, penso esattamente quel che ho detto.”
“Anche io. Solo non andava detto in quel modo.”
“Infatti. Sei uno stronzo.”
“Lo so. È che non ti sopporto, non ti reggo. E non parlo di adesso, parlo già della palestra. Ti atteggi come una dea, cazzo, guardi tutti dall’alto in basso anche se sei alta come un barattolo. E poi hai questa voce antipatica, stridula, che martella nella testa.”
Fermo la vena pulsante che è ripartita da capo mentre ricominci a singhiozzare con gli occhi sgranati.
“Okay, scusa, basta.” Le ore qui dentro. “Basta, non ha senso. Mi piacevi, ma mi stai troppo sulle palle. Anche se fossi l’unica rimasta al mondo non ce la farei, non con te.”
“Guarda che per me è lo stesso!”
“Appunto.” Poggio le mani sul volante. “Forse gli ultimi al mondo lo siamo per davvero.”
“Non dirlo neanche.”
Là fuori, in queste ore, può essere successa qualsiasi cosa. La pandemia potrebbe aver spazzato via la civiltà.
Le ore passate, le ore.
Chiusi in un’auto, tra quattro mura scrostate, una lampadina che pende dal soffitto. Una canzone nella testa.
“Senti,” lo dico senza guardarti, “ho una proposta.”
Asciughi le lacrime, hai ancora la voce rotta e il respiro intasato. “Quale?”
“Amami. Come se avessimo un solo giorno per far l’amore.” Hai gli occhi come fanali nel buio. “Amami. Come se fossimo soli al mondo: amami.”
Ora io ti guardo, ora tu mi guardi.
“Ora l’universo trattiene il respiro, mentre noi, qui, camminiamo sul filo.”
È l’attimo più lungo della mia vita, e forse anche della tua.
Ora io ti guardo, ora tu mi guardi.
Ora io ti cerco.
Ora ti nascondi.
Ora io ti trovo.
Ora siamo qui.
Ora, e ancora, così.
Ora che ti tocco, ora non mi blocco.
Ora le mie mani ti accarezzano la schiena.
Ora la mia piena scioglie la catena.
Ora una scintilla, poi un antro di balena.
Ora ti ringrazio per essere nata.
Per essere te.
Perché t’ho trovata, quell’ora, quel giorno, persa come me.
Ora ti accarezzo, e lo fai anche te.
Amami.
Come se fossimo soli al mondo, soli al mondo.
Amami.
Prima di morire, conoscere l’amore.
Prima dell’inverno, conoscere l’amore.
L’amore.
Le ore.
La porta basculante si apre, forzata dall’esterno.
I due operatori in tuta gialla anti-contaminazione illuminano il garage buio: la lampadina che pende dal soffitto ormai bruciata.
C’è una Honda grigia e tre pareti di cemento dall’intonaco scrostato.
Il rilevatore nella mano guantata segnala cospicue tracce umane all’interno.
L’uomo si accosta, illumina l’abitacolo.
L’espressione perplessa trapela anche attraverso il casco isolante.
“Cos’è successo qua dentro?” incalza quello dietro, la voce resa cupa dallo scafandro.
Lui tentenna, sposta la torcia più volte su un sedile e poi l’altro. “Non ne sono sicuro,” mormora.
“Sii più specifico.”
“Forse,” si scosta dall’auto con un sospiro che l’ossigeno amplifica, “forse il rilevatore è guasto. Non c’è nessuno qui.”
Ora siamo qui, ora e ancora, così.
Ore, le ore.
Le ho contate ogni settimana per rivederti, fino a quell’ora, quel giorno, ogni settimana, ogni volta come fosse l’ultima possibile.
Le ore.
Due soltanto, due, per scambiare poche parole in una palestra poco frequentata, mezzo saluto, un’occhiata indifferente.
Ore che volano, passano, ore, la settimana intera e poi ancora.
Per rivederti, due ore di più, ancora due, e se non c’eri, ore perdute, fino alla prossima, le prossime due.
Ora siamo qui, senza che le ore abbiano più significato.
Perché t’ho trovata quell’ora, quel giorno, persa come me.
Ora ti ringrazio per essere nata.
Per essere te.
Prima di morire, conoscere l’amore.
Prima dell’inverno, conoscere l’amore.
Avevo in mente quella canzone, quando è iniziato tutto. Era l’ultima che suonava sulla playlist nell’USB della macchina.
Quella canzone lì.
“Quante ne sono passate?”
“Di giornate?”
“Di ore.”
Non lo so. Ho smesso di contarle, già da parecchio.
Continuiamo a guardare la porta basculante chiusa: noi siamo dentro, loro sono fuori.
Tre mura di cemento dall’intonaco scrostato e una porta basculante chiusa, la Honda parcheggiata nel mezzo, una lampadina pendente: tutto uno spettacolo migliore delle nostre facce stanche, perse, arrabbiate.
Abbiamo percorso ogni centimetro percorribile di questo spazio angusto. Ci siamo seduti in auto e poi alzati. Davanti, dietro, aperto e chiuso portiere. Abbiamo guardato da sotto il battente sperando che loro se ne andassero, ma loro sono sempre lì, barcollanti, assenti, infaticabili.
“È colpa tua.” Lo dici e lo ridici, come cambiasse la realtà delle cose. “È tutta colpa tua.”
“Certo.” La pandemia, il caos, le combinazioni di eventi, gli incontri casuali, le scelte fatte in un momento. Colpa mia.
“Dovevo arrivare alla mia macchina.” Lo stesso tono spezzato, sempre uguale. “Potevo farcela.”
“E dillo ancora, tanto ormai.”
I passi strascicati degli infetti, fuori dalla porta, nel locale dei garage.
Scuoti la testa e quegli occhi chiarissimi che ti ritrovi. “Sei proprio uno stronzo.”
“Certo.”
Sono ore, forse giorni, che voglio dirtelo, dirti tutto, dalla prima all’ultima lettera, e ogni volta penso che non è ancora il momento. Che ne verrà uno migliore. Che ci troveranno e ci porteranno via da qui, e che non meriti di sapere tutto quanto, tutta la storia.
Vaghiamo tra quattro mura, sei metri per tre, con un’auto nel mezzo e una lampadina che pende dal soffitto. Se si brucia, neanche più quella.
“Dovevo arrivare alla mia macchina.” Singulto e viso arrossato. “Potevo farcela.”
Erano cento metri. Non potevi farcela. T’avrebbero presa prima, morsicata, fatta a pezzi. E pure me, perché sarei venuto a prenderti, difenderti, proteggerti, anche se non te lo meriti.
Non ti meriti il mio sacrificio.
Non ti meriti che ti abbia trascinata dentro il passo carraio, nel locale garage, dentro il mio, che era aperto, perché stavo uscendo. Dovevo lasciarti in strada.
“Sei proprio uno stronzo.”
Lo sono. Verso me stesso: mi sono sempre trattato male. Sempre fatto del male. Con te e quelle come te.
“Dovevi proprio uscire stasera?” Ammesso che sia ancora sera, che sia ancora oggi. Le ore passano e non abbiamo nulla per contarle.
“Ma che cazzo vuoi, è sabato!”
“E dovevi proprio venire al Jamaika.”
“Sì, infatti.”
Cento metri da casa mia, uno stupido pub, sabato sera. E io stupido che ho pensato d’uscire, anziché stare a casa a giocare alla Play Station. Magari t’incontravo. Per caso, come è già successo, qui intorno, o in altri posti meno logici. Per un saluto accennato, indifferente.
Magari t’incontravo.
E ti ho incontrata, nel mezzo dell’apocalisse. Il caso, a volte. Chiudersi in garage, aspettare che gli infetti vadano via; ma non se ne sono andati, sono rimasti lì fuori, nel passaggio buio, a trascinarsi e mormorare.
Sono ancora lì, da ore e ore. Forse di più.
Non se ne andranno mai.
“E hai pure perso il telefono!” Lo dici con quella nota stridula che sono unghie sulla lavagna. La tua voce è tutto un fastidio viscerale.
“E le chiavi della macchina.”
“E bravo, a posto così.”
Le ho perse per portarti via dalla strada e dal caos, sgomitando con gli infetti. “Potevo lasciarti lì.”
“E dovevi, cazzo!”
Scuoto la testa.
“E adesso moriremo qui.”
Possibile. Probabile, per mera statistica.
Sbatti le mani sui tuoi pantaloni leggeri color vinaccia e le porti al viso. Singhiozzi.
Volevo salvarti, non lo dico.
Vorrei dirlo, da ore. Un sacco di ore.
Vorrei dirti anche il resto.
“Cazzo, che eroe che sei!”
Eroe, le ore.
“Dacci un taglio. Anche basta.”
“Dovevi lasciarmi arrivare alla macchina, ce l’avrei fatta!”
Volevo salvarti, non lo dico.
“E adesso devo morire qui dentro.”
“Volevo salvarti,” l’ho detto.
Mi guardi con tutto quell’astio che hai sempre avuto, che non ho mai capito. “Ma se praticamente neanche ti conosco.”
“Vero.”
“Non potevi farti i cazzi tuoi, no?!”
“Non potevo.” Non dopo averti trovata così, in strada, con dietro gli infetti e il mondo che di colpo non aveva più una direzione.
“Perché?!”
Perché mi hai sempre fatto uno strano effetto, non lo dico.
“Perché provo qualcosa per te,” l’ho detto.
Resti in silenzio e con gli occhi dilatati, ma non è sorpresa, è banale indignazione. Ho sempre quella canzone in testa.
Sbatti i palmi e agiti appena le mani, come di fronte alle cose patetiche della vita, con quel sorriso tanto amabile quanto odioso. “Siamo alla pazzia.”
La pazzia è qui dentro e non là fuori, con le folle di malati, il panico e la distruzione, la fine dei giorni. Le ore che passano.
“È la verità.”
“Oh,” il tono è compassionevole solo per la prima sillaba, poi diventa acre, “ma guarda che lo sapevo.”
“Certo.”
“Lo sapevo, invece. Stavi sempre a guardarmi, in palestra.”
“Certo. È come mi guardi tu, il problema.”
“Come ti guardo io?”
“Come adesso: con tutto ‘sto astio, ‘sto fastidio.”
“E ci mancherebbe pure!”
Due ore, quelle due ore di martedì per incontrarti in palestra, non lo dico. “Pensa che volevo venire pure di giovedì, perché sapevo che c’eri tu. Ma non riuscivo con gli orari.”
“E meno male.”
“Posso dirtelo?”
Alzi di spalle. “Tanto ormai.”
“Sì, ormai.”
Prendo un respiro per il momento che ho atteso da così tanto tempo.
“Sei,” la scelta di termini più difficile, “sei un dito in culo. Sei la ragazza più irritante del mondo. Non so come si faccia a stare con te più di dieci minuti. Se ho ancora sanità mentale dopo tutte queste ore è perché ho il principio inchiodato nella testa di sopportare tutto e tutti, ma tu vai oltre ogni mio limite. Sei la somma dei peggiori difetti che una donna può avere, a parte essere figa, e io non so neanche da dove iniziare a elencarli.”
Silenzio.
Hai le iridi che sembrano lune e le labbra piegate all’ingiù. “Hai finito?” Lo dici con la voce che oscilla.
“Ho finito.” Non un grammo d’aria nei polmoni e sempre quella canzone in testa.
Scende un silenzio atroce. Ora io ti guardo, ora tu mi guardi.
Scoppi a piangere senza un suono e con le mani a coprire metà del viso. Gli infetti, fuori dalla porta, si lamentano come a farti il verso.
“E che cazzo, qualcuno doveva dirtelo prima o poi, oh.”
Persino i tuoi singulti sono una tortura cinese.
Passano minuti che sembrano ore.
Ce ne vorrebbero molte altre, di ore, per dimenticare tutto questo.
Sospiro. “Ehi.” Fai segno di no, di lasciar stare. Se riesci a farmi sentire in colpa è solo perché ho un animo gentile. “Dai, sfogati tu. Di’ quello che pensi, di me, di tutto. Vai.”
Ti levi le lacrime a ditate nervose. “Mi sei sempre stato sul culo, sempre.”
“Lo so. Ma non so il perché.”
“Perché ti dai un sacco di arie, ti credi chissà chi.”
“Io?”
“Invece sei stupido e insulso.”
“Vai.”
“Non sei simpatico, non fai ridere, non c’è niente di te che sia interessante, nulla. Sei come un buco nero che assorbe la luce degli altri.”
“Questa l’hai preparata, si sente.”
“Ma io dovevo essere salvata proprio da te?!”
“Io in te dovevo imbattermi quando sono uscito in strada a vedere che stava capitando?!”
Restiamo così, soli al mondo, tra quattro mura scrostate, con un’auto in mezzo che non posso mettere in moto. Ci vuole un po’ per guardarti alzare di nuovo lo sguardo, per la prima volta carico di una qualche sensazione che non intendo.
“Mi stavi seguendo, vero?”
“Certo che no.”
“Sì, invece. Ne sei capace, te lo si legge in faccia. Hai una faccia da psicopatico.”
L’ho fatto, una volta, seguirti. Volevo capire dove abiti, per incontrarti più facilmente per caso, un giorno: non lo dico.
“Pensavo avessi finito.”
“Ammetti che mi stavi seguendo.”
“L’ho fatto una volta,” l’ho detto, “ma ti ho persa al primo semaforo. Come segugio faccio schifo.”
“Lo sapevo! Psicopatico!”
“Piantala. Io abito qui. Questa è casa mia, anzi è il mio garage. Sei TU che sei andata al Jamaika, che hai parcheggiato qui davanti. È colpa tua.”
“Sì, certo.”
“Sono sceso giù perché volevo prendere la macchina e andare a fare un giro in notturna. Poi ho sentito le urla, il caos, sono uscito in strada. E ho visto te.”
“Sì, certo.”
“Quando ero lì, quando ho capito che era l’apocalisse, sai cosa ho pensato?”
“Non lo voglio sapere.”
Che c’era una sola persona che desideravo stesse bene, ed eri tu: non lo dico.
“Che se t’incontro in versione infetta non lo so se ho il coraggio di abbatterti.” L’ho detto.
Hai la faccia grave come un lutto. “Tu sei del tutto pazzo.”
“Volevo salvarti, non ho pensato ad altro.”
“Non hai pensato, appunto. Adesso siamo chiusi qui, senza un telefono, senza le chiavi dell’auto. Senza niente da mangiare, da bere, con quei mostri lì fuori.”
“Arriveranno i soccorsi.”
“E se non arrivano?”
Non ho una risposta. Chiudi ogni contatto aprendo la portiera del passeggero, salendo in macchina e isolandoti dal resto del mondo, che sono soltanto io.
Ci metto minuti per aprire quella del guidatore e salire a mia volta.
“Aspetta,” ammonisco quando stai già per scendere, “ho esagerato, d’accordo? È una situazione estrema e siamo sotto pressione.”
“Io non ho esagerato niente, penso esattamente quel che ho detto.”
“Anche io. Solo non andava detto in quel modo.”
“Infatti. Sei uno stronzo.”
“Lo so. È che non ti sopporto, non ti reggo. E non parlo di adesso, parlo già della palestra. Ti atteggi come una dea, cazzo, guardi tutti dall’alto in basso anche se sei alta come un barattolo. E poi hai questa voce antipatica, stridula, che martella nella testa.”
Fermo la vena pulsante che è ripartita da capo mentre ricominci a singhiozzare con gli occhi sgranati.
“Okay, scusa, basta.” Le ore qui dentro. “Basta, non ha senso. Mi piacevi, ma mi stai troppo sulle palle. Anche se fossi l’unica rimasta al mondo non ce la farei, non con te.”
“Guarda che per me è lo stesso!”
“Appunto.” Poggio le mani sul volante. “Forse gli ultimi al mondo lo siamo per davvero.”
“Non dirlo neanche.”
Là fuori, in queste ore, può essere successa qualsiasi cosa. La pandemia potrebbe aver spazzato via la civiltà.
Le ore passate, le ore.
Chiusi in un’auto, tra quattro mura scrostate, una lampadina che pende dal soffitto. Una canzone nella testa.
“Senti,” lo dico senza guardarti, “ho una proposta.”
Asciughi le lacrime, hai ancora la voce rotta e il respiro intasato. “Quale?”
“Amami. Come se avessimo un solo giorno per far l’amore.” Hai gli occhi come fanali nel buio. “Amami. Come se fossimo soli al mondo: amami.”
Ora io ti guardo, ora tu mi guardi.
“Ora l’universo trattiene il respiro, mentre noi, qui, camminiamo sul filo.”
È l’attimo più lungo della mia vita, e forse anche della tua.
Ora io ti guardo, ora tu mi guardi.
Ora io ti cerco.
Ora ti nascondi.
Ora io ti trovo.
Ora siamo qui.
Ora, e ancora, così.
Ora che ti tocco, ora non mi blocco.
Ora le mie mani ti accarezzano la schiena.
Ora la mia piena scioglie la catena.
Ora una scintilla, poi un antro di balena.
Ora ti ringrazio per essere nata.
Per essere te.
Perché t’ho trovata, quell’ora, quel giorno, persa come me.
Ora ti accarezzo, e lo fai anche te.
Amami.
Come se fossimo soli al mondo, soli al mondo.
Amami.
Prima di morire, conoscere l’amore.
Prima dell’inverno, conoscere l’amore.
L’amore.
Le ore.
*
La porta basculante si apre, forzata dall’esterno.
I due operatori in tuta gialla anti-contaminazione illuminano il garage buio: la lampadina che pende dal soffitto ormai bruciata.
C’è una Honda grigia e tre pareti di cemento dall’intonaco scrostato.
Il rilevatore nella mano guantata segnala cospicue tracce umane all’interno.
L’uomo si accosta, illumina l’abitacolo.
L’espressione perplessa trapela anche attraverso il casco isolante.
“Cos’è successo qua dentro?” incalza quello dietro, la voce resa cupa dallo scafandro.
Lui tentenna, sposta la torcia più volte su un sedile e poi l’altro. “Non ne sono sicuro,” mormora.
“Sii più specifico.”
“Forse,” si scosta dall’auto con un sospiro che l’ossigeno amplifica, “forse il rilevatore è guasto. Non c’è nessuno qui.”

Different Staff- Admin

- Messaggi : 722
Punti : 2103
Infamia o lode : 7
Data di iscrizione : 26.02.21
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
E' tutto un po' troppo assurdo in questo racconto che tratta di zombies. Non sono riuscito a capire questi due che si sono conosciuti in una apparentemente normale palestra mentre fuori un'epidemia che crea gli zombi imperversa. Loro ci vanno tutti i giorni per due ore di seguito e ... i mostri dove sono? Poi lui la salva da quelli e si rinchiudono nel garage di lui rinfacciandosi cose senza senso mentre fuori imperversano gli zombi e alla fine... beh no non lo spoilero.

Antonio Borghesi- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 573
Punti : 625
Infamia o lode : 3
Data di iscrizione : 08.01.21
Età : 83
Località : Firenze
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Piaciuto moltissimo, l'elogio dell'assurdo.
Con quel finale dolcissimo dopo un racconto duro, aspro, antipatico.
Lui, innamorato della bellezza di lei che non sopporta per quanto è stronza.
Lei che non lo può patire ma le circostanze la costringono per ore con lui che nasconde la sua fragilità dietro a un'eccessiva aggressività.
E se volgiamo ceracre un'interpretazione metaforica, gli zombie sono tutti coloro che per un motivo o epr l'altro si oppongono all'amore di questio novelli romeo e Giulietta (e non è detto che gli zombie rappresentino delle persone, potrebbero essere tutte le "seghe mentali" che ognuno di noi costruisce tra sè e il mondo, tra sè e gli altri...)
Boh, forse sono andato troppo oltre.
Con quel finale dolcissimo dopo un racconto duro, aspro, antipatico.
Lui, innamorato della bellezza di lei che non sopporta per quanto è stronza.
Lei che non lo può patire ma le circostanze la costringono per ore con lui che nasconde la sua fragilità dietro a un'eccessiva aggressività.
E se volgiamo ceracre un'interpretazione metaforica, gli zombie sono tutti coloro che per un motivo o epr l'altro si oppongono all'amore di questio novelli romeo e Giulietta (e non è detto che gli zombie rappresentino delle persone, potrebbero essere tutte le "seghe mentali" che ognuno di noi costruisce tra sè e il mondo, tra sè e gli altri...)
Boh, forse sono andato troppo oltre.
______________________________________________________


paluca66- Maestro Jedi

- Messaggi : 1341
Punti : 1440
Infamia o lode : 8
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 57
Località : Milano
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Devo dire con tutta onestà che le letture fino ad adesso mi sono piaciute e mi hanno tenuto buona compagnia.
Non sono nemmeno a metà strada e chissà quante sorprese mi aspettano.
Questo racconto, scritto con grande animosità, è tra i migliori .
Ai miei tempi essere tra i migliori era un difetto, quelli gagliardi stavano all'ultimo banco.
Scherzo.
Ti abbraccio.
Non sono nemmeno a metà strada e chissà quante sorprese mi aspettano.
Questo racconto, scritto con grande animosità, è tra i migliori .
Ai miei tempi essere tra i migliori era un difetto, quelli gagliardi stavano all'ultimo banco.
Scherzo.
Ti abbraccio.
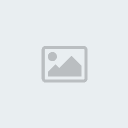
tommybe- Maestro Jedi

- Messaggi : 1233
Punti : 1334
Infamia o lode : 19
Data di iscrizione : 18.11.21
Età : 72
Località : Roma
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Cosa dire?
Che l'ho capito solo a tratti, che il fluire delle vicende non è lineare, che i personaggi sono un po' macchettistici e poco profondi?
Arrivo alla fine e non ho compreso bene, dovrei rileggere e farlo piano, ragionandoci un po'.
Ma qui sorge il problema: non ne ho voglia. Preferisco andare a farmi una nuotata.
La storia non è riuscita a catturarmi per farmi venire veramente voglia di capire.
Li lascio lì nel loro garage e se li trovano o se non ci sono mai stati, mi importa il giusto.
Che l'ho capito solo a tratti, che il fluire delle vicende non è lineare, che i personaggi sono un po' macchettistici e poco profondi?
Arrivo alla fine e non ho compreso bene, dovrei rileggere e farlo piano, ragionandoci un po'.
Ma qui sorge il problema: non ne ho voglia. Preferisco andare a farmi una nuotata.
La storia non è riuscita a catturarmi per farmi venire veramente voglia di capire.
Li lascio lì nel loro garage e se li trovano o se non ci sono mai stati, mi importa il giusto.
Ultima modifica di gipoviani il Lun Lug 31, 2023 5:38 pm - modificato 3 volte.
gipoviani- Padawan

- Messaggi : 273
Punti : 306
Infamia o lode : 3
Data di iscrizione : 01.05.21
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Ciao Penna. Questo è stato il primo racconto che ho letto, m'incuriosiva e intrigava il titolo. Amo l'opera famosa di Erasmo da Rotterdam e speravo fosse un racconto in qualche modo legato all'Elogio che tutti conosciamo. Scoprire che non lo era mi aveva scoraggiato e ho preferito rimandare il commento per non essere condizionato dalla personalissima delusione, perché tu non avevi colpa, era solo un mio film. E ho fatto bene, perché il tuo è un racconto che mi è piaciuto leggere, a distanza di qualche giorno. Non conoscevo la canzone di Jovanotti, l'ho scoperta inserendo in internet le parole, volevo capire se era una canzone inventata o esistente. Il filone è quello noto: una mattina ti svegli e scopri di fare parte di un manipolo di persone scampate dall'infezione che trasforma l'umanità in zombie. Dal presupposto indaghi quella che è una infatuazione che capita spesso, di cui il protagonista narratore è preda. Ciò che più ho apprezzato del tuo lavoro è l'inseguirsi tra dialogo e pensiero, la prudenza consigliata che cede all'impulsività dello sfogo. Non ho ben capito il finale, poi ce lo spiegherai, ma volendo dare una patente filosofica al racconto (così sono in pace anche col buon Erasmo) potrebbe essere che il rilevatore percepisca la presenza di un possibile contatto umano, che alla prova dell'amore che non c'è si dissolve o diventa invisibile. Ma è più probabile che non abbia capito il finale. Pochi refusi, una ripetizione a fronte di uno stile veloce, urgente e ben dosato Grazie per averci fatto leggere il tuo lavoro, cara Penna.

digitoergosum- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 841
Punti : 936
Infamia o lode : 6
Data di iscrizione : 04.03.21
Età : 61
Località : Idro (BS)
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Non l'ho mai fatto in tredici step, ma questa volta chiedo l'aiuto da casa.
Chi ha capito cosa succede alla fine me lo può spiegare? Dove diavolo sono finiti?
Non voglio aspettare la fine dello step che lo dica l'autore ma voglio che lo dicano gli altri utenti perché veramente mi sento uno stupido.
Detto questo, mi è piaciuto un sacco questo scambio. È assurdo, ma è proprio questo che lo rende reale e dinamico.
Quello che mi ha disturbato è il narratore. In un racconto così ricco di dialoghi, forse un narratore onnisciente sarebbe stato più azzeccato. Tra il ritmo dei dialoghi e i pensieri del narratore, si crea non poca confusione che appesantisce la lettura.
Chi ha capito cosa succede alla fine me lo può spiegare? Dove diavolo sono finiti?
Non voglio aspettare la fine dello step che lo dica l'autore ma voglio che lo dicano gli altri utenti perché veramente mi sento uno stupido.
Detto questo, mi è piaciuto un sacco questo scambio. È assurdo, ma è proprio questo che lo rende reale e dinamico.
Quello che mi ha disturbato è il narratore. In un racconto così ricco di dialoghi, forse un narratore onnisciente sarebbe stato più azzeccato. Tra il ritmo dei dialoghi e i pensieri del narratore, si crea non poca confusione che appesantisce la lettura.

ImaGiraffe- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 796
Punti : 866
Infamia o lode : 2
Data di iscrizione : 04.02.21
Età : 37
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Tre mura di cemento dall’intonaco scrostato e una porta basculante chiusa, la Honda parcheggiata nel mezzo, una lampadina pendente: tutto uno spettacolo migliore delle nostre facce stanche, perse, arrabbiate.
Abbiamo percorso ogni centimetro percorribile di questo spazio angusto. Ci siamo seduti in auto e poi alzati. Davanti, dietro, aperto e chiuso portiere.
Scusa autore ma se c’è una moto nel mezzo, l’auto dove sta? Non mi pare così angusto un garage con tanto spazio da contenere un’auto e una moto (nel mezzo)
Vaghiamo tra quattro mura, sei metri per tre, con un’auto nel mezzo e una lampadina che pende dal soffitto. Se si brucia, neanche più quella.
Adesso c’è l’auto nel mezzo… e la moto?
Ok, d’accordo autore. Rinuncio alla logica. Il racconto forse ne ha una o forse non ne ha affatto. O ci si “entra” oppure no. Io purtroppo non ci sono riuscita a empatizzare coi protagonisti eppure hai citato la canzone di Jova e a me lui, in alcune cose, piace davvero tanto.
Scusa ma, difetto mio, non l’ho capito.
Abbiamo percorso ogni centimetro percorribile di questo spazio angusto. Ci siamo seduti in auto e poi alzati. Davanti, dietro, aperto e chiuso portiere.
Scusa autore ma se c’è una moto nel mezzo, l’auto dove sta? Non mi pare così angusto un garage con tanto spazio da contenere un’auto e una moto (nel mezzo)
Vaghiamo tra quattro mura, sei metri per tre, con un’auto nel mezzo e una lampadina che pende dal soffitto. Se si brucia, neanche più quella.
Adesso c’è l’auto nel mezzo… e la moto?
Ok, d’accordo autore. Rinuncio alla logica. Il racconto forse ne ha una o forse non ne ha affatto. O ci si “entra” oppure no. Io purtroppo non ci sono riuscita a empatizzare coi protagonisti eppure hai citato la canzone di Jova e a me lui, in alcune cose, piace davvero tanto.
Scusa ma, difetto mio, non l’ho capito.

Petunia- Moderatore

- Messaggi : 2266
Punti : 2499
Infamia o lode : 43
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 60
Località : Prato
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Arrivata alla fine, ma anche durante la lettura, ho detto tra me e me: wow!
Wow per tutto: i protagonisti - così ben delineati psicologicamente da dialoghi serrati e senza un qualcosa in meno o in più; il garage, uguale ad almeno un garage che abbiamo avuto o visto: spoglio, buio e triste, se non inquietante con la poca luce di una lampadina.
Le personalità dei protagonisti: lui subito ne ha davvero dello psicopatico, silenzioso, con tanti pensieri che premono per uscire ma lui li vorrebbe trattenere, far sì che siano solo suoi, ma poi “evadono”, secchi e senza possibilità di replica. Lei, altezzosa, che crede di avere ragione ad ogni costo.
Il ritmo: mi viene da dire “imperioso”: tiene per tutto il racconto. Le frasi, secche, corte, dure sono davvero adatte per creare un’atmosfera che fa trattenere il fiato.
Anche il richiamo ogni tanto degli “infetti” contribuisce a rendere la drammaticità del momento. E francamente poco mi è interessato di sapere cosa fosse successo là fuori.
Insomma un racconto scritto davvero bene, con una scrittura sicura e determinata a tenere legato il lettore fino a quel finale sconcertante, che si presta a tante interpretazioni.
Mio parere personale: è stata vincente la scelta di impostare il racconto in prima persona, ha evitato di dover raccontare tanto altro per rendere atmosfera e situazione, rompendo il ritmo incalzante che invece ne è scaturito fin dalle prime righe.
Davvero un racconto tosto. Complimenti.
Wow per tutto: i protagonisti - così ben delineati psicologicamente da dialoghi serrati e senza un qualcosa in meno o in più; il garage, uguale ad almeno un garage che abbiamo avuto o visto: spoglio, buio e triste, se non inquietante con la poca luce di una lampadina.
Le personalità dei protagonisti: lui subito ne ha davvero dello psicopatico, silenzioso, con tanti pensieri che premono per uscire ma lui li vorrebbe trattenere, far sì che siano solo suoi, ma poi “evadono”, secchi e senza possibilità di replica. Lei, altezzosa, che crede di avere ragione ad ogni costo.
Il ritmo: mi viene da dire “imperioso”: tiene per tutto il racconto. Le frasi, secche, corte, dure sono davvero adatte per creare un’atmosfera che fa trattenere il fiato.
Anche il richiamo ogni tanto degli “infetti” contribuisce a rendere la drammaticità del momento. E francamente poco mi è interessato di sapere cosa fosse successo là fuori.
Insomma un racconto scritto davvero bene, con una scrittura sicura e determinata a tenere legato il lettore fino a quel finale sconcertante, che si presta a tante interpretazioni.
Mio parere personale: è stata vincente la scelta di impostare il racconto in prima persona, ha evitato di dover raccontare tanto altro per rendere atmosfera e situazione, rompendo il ritmo incalzante che invece ne è scaturito fin dalle prime righe.
Davvero un racconto tosto. Complimenti.
______________________________________________________
"Quindi sappiatelo, e consideratemi pure presuntuoso, ma io non scrivo per voi. Scrivo per me e, al limite, per un'altra persona che può capire. Spero di conoscerla un giorno… G. Laquaniti"
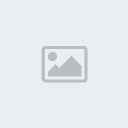
Susanna- Maestro Jedi

- Messaggi : 2225
Punti : 2450
Infamia o lode : 20
Data di iscrizione : 03.02.21
Età : 67
Località : Rumo (TN)
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Non è facile commentare un racconto come questo: se l'Autore ha volutamente tentato di "uscire dagli schemi", per me ci è riuscito. Il racconto colpisce anzitutto per stile e ritmo. L'utilizzo della prima persona a mio parere va di pari passo con la scelta di utilizzare spesso frasi brevi e immediate. Di conseguenza il ritmo è sempre alto, è come se avessi letto il testo trattenendo il respiro.
Confesso candidamente di non conoscere la canzone di Jovanotti, tant'è che ho pensato a un inizio poetico come introduzione a ciò che accade dopo e che fissa l'argomento "amore" come leitmotiv del racconto. Effettivamente è così anche se forse il sentimento espresso dal protagonista narrante è quantomeno non convenzionale. Quindi mi chiedo se questo "amore" trova il suo compimento a causa di ciò che accade fuori dal garage oppure è il frutto della pazzia latente del protagonista? Dopo tutto la ragazza lo definisce pazzo e psicopatico più volte. Nella mia coscienza di lettore sono giunto a una conclusione: poco importa ciò che c'è fuori, il significato vero sta tutto dentro al garage, "dentro i protagonisti".
Io credo che questi due si amino veramente, per cui il trovarsi rinchiusi magari l'hanno fatto di proposito e non per caso o per sfuggire a qualcosa. L'isolamento nel garage è l'occasione per far uscire tutto ciò che c'è di negativo tra loro, un'occasione di chiarimento oserei dire "finale".
Finale perché poi il finale del racconto, mi scuso per il gioco di parole, è di fatto molto aperto a qualsiasi interpretazione.
Se volessi mantenere la mia linea circa la poca importanza di ciò che accade all'esterno del garage, direi che i due amanti sono fuggiti da quella prigione "necessaria", consapevoli a quel punto del rapporto importante e inscindibile che c'è tra loro.
Scritto bene.
Grazie
Confesso candidamente di non conoscere la canzone di Jovanotti, tant'è che ho pensato a un inizio poetico come introduzione a ciò che accade dopo e che fissa l'argomento "amore" come leitmotiv del racconto. Effettivamente è così anche se forse il sentimento espresso dal protagonista narrante è quantomeno non convenzionale. Quindi mi chiedo se questo "amore" trova il suo compimento a causa di ciò che accade fuori dal garage oppure è il frutto della pazzia latente del protagonista? Dopo tutto la ragazza lo definisce pazzo e psicopatico più volte. Nella mia coscienza di lettore sono giunto a una conclusione: poco importa ciò che c'è fuori, il significato vero sta tutto dentro al garage, "dentro i protagonisti".
Io credo che questi due si amino veramente, per cui il trovarsi rinchiusi magari l'hanno fatto di proposito e non per caso o per sfuggire a qualcosa. L'isolamento nel garage è l'occasione per far uscire tutto ciò che c'è di negativo tra loro, un'occasione di chiarimento oserei dire "finale".
Finale perché poi il finale del racconto, mi scuso per il gioco di parole, è di fatto molto aperto a qualsiasi interpretazione.
Se volessi mantenere la mia linea circa la poca importanza di ciò che accade all'esterno del garage, direi che i due amanti sono fuggiti da quella prigione "necessaria", consapevoli a quel punto del rapporto importante e inscindibile che c'è tra loro.
Scritto bene.
Grazie
______________________________________________________
"Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci lectorem delectando pariterque monendo."
"Ottiene il risultato migliore chi - nell'opera letteraria - ha saputo unire l'utile col piacevole, divertendo e ammaestrando nello stesso momento il lettore."
Orazio, Ars Poetica, vv. 343-344
Avei l'amel su i laver e 'l cutel an sacòcia.

Molli Redigano- Maestro Jedi

- Messaggi : 1025
Punti : 1116
Infamia o lode : 2
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 43
Località : Torino
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Ho iniziato la lettura pensando "Oh, cazzo! Con la scusa del genere libero qualcuno ha scelto il poema?", poi invece era solo un canzone di Jovanotti (che non conoscevo), e per fortuna quello che ho trovato oltre è stato più piacevole. Bella la situazione, bello lo scambio di battute, bello il contrasto tra il pensiero e le parole che riescono a evadere dalla bocca.
Pezzo teatrale di piacevole lettura. Il finale? Non so, credo di non averlo capito, ma forse non mi interessa più di tanto.
Il resto mi è piaciuto parecchio.
Complimenti.
Grazie
@Petunia credo che con Honda l'autore si riferisca a un modelo di auto, non di moto.
Pezzo teatrale di piacevole lettura. Il finale? Non so, credo di non averlo capito, ma forse non mi interessa più di tanto.
Il resto mi è piaciuto parecchio.
Complimenti.
Grazie
@Petunia credo che con Honda l'autore si riferisca a un modelo di auto, non di moto.
______________________________________________________
I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono cinque o sei in tutto. Gli altri fanno volume.

CharAznable- Maestro Jedi

- Messaggi : 1002
Punti : 1125
Infamia o lode : 13
Data di iscrizione : 22.02.21
Età : 48
Località : Magenta
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Penso sia quel genere di racconti che hanno per alcuni un indice di gradimento altissimo e per altri il contrario.
Io sono tra gli ultimi, perché non l'ho capito.
Non ho capito se si trattava di zombie, come qualcuno ha scritto, o di una revisione esasperata del covid.
Comunque, a prescindere dal personalissimo giudizio, il ritmo è sempre elevatissimo, le battute incalzanti, i personaggi ben delineati, anche se un po' stereotipati, per cui si legge volentieri.
Io sono tra gli ultimi, perché non l'ho capito.
Non ho capito se si trattava di zombie, come qualcuno ha scritto, o di una revisione esasperata del covid.
Comunque, a prescindere dal personalissimo giudizio, il ritmo è sempre elevatissimo, le battute incalzanti, i personaggi ben delineati, anche se un po' stereotipati, per cui si legge volentieri.

FedericoChiesa- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 529
Punti : 590
Infamia o lode : 3
Data di iscrizione : 24.04.21
Età : 57
Località : Milano
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Difficile lettura per via della scrittura personalissima, ma non sempre lineare e delle ripetizioni di frasi e parole. Racconto surreale con un finale che mi disorienta. Quindi ho letto fin qui il dialogo tra due presenze che alla fine non ci sono, o non ci sono mai state? L’insistenza sul tempo che significa? Carpe diem, amami ora che domani è già tardi – vero, ma è scontato anche senza tirare in ballo apocalittiche epidemie. Siamo tutti fantasmi evanescenti dei quali alla fine nulla rimane? O ancora e ancora… ma qual è il messaggio? Personalmente trovo monotono il linguaggio ripetitivo, limite mio, però mi annoio “Non lo dico, l’ho detto. “ “Ora ti guardo, ora mi guardi…” mi ritorna in mente come un mantra ossessivo compulsivo.
Della citata canzone di Jovanotti ne avrei volentieri fatto a meno. Non amo quella musica.
Della citata canzone di Jovanotti ne avrei volentieri fatto a meno. Non amo quella musica.
mirella- Padawan

- Messaggi : 293
Punti : 347
Infamia o lode : 5
Data di iscrizione : 08.01.21
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Racconto dal timbro molto originale e dal gran ritmo.
Non so se sia un racconto metaforico o una pura e semplice apocalisse zombi, però la lettura è divertente.
Tra l'altro la lettura mi ha fatto pensare ai sempre più difficili rapporti tra uomini e donne. Non so, sarà l'effetto Barbie(che io non ho visto) ma in giro sui social è tutto un proliferare di articoli e discussioni sul patriarcato, sul maschilismo, con le posizioni contrapposte che non fanno nessuna una bella figura, con battute da caserma da una parte e ideologie estremiste e intransigenti che troncano sul nascere qualsiasi mediazione dall'altra. La sensazione è che lo scontro ideologico diventerà sempre più aspro, senza potere arrivare a una sintesi.
Comunque, tornando al tuo racconto, la cosa che più mi è piaciuta sono i dialoghi, sinceri, senza cercare sensazionalismi. Seppur diversissimo il racconto, per una sorta di incomunicabilità di fondo, mi ha ricordato la storia di un altro step, dove protagonisti erano due archeologhi o qualcosa del genere.
Incomunicabilità tra i due sessi, o difficoltà nella comunicazione tra i due sessi, questo mi pare il tema del racconto, messo all'interno di una situazione estrema.
Ciò che mi lascia perplesso è il finale: perché non ci sono? Dove sono finiti? Perché non si trovano neppure i resti? Ci sto ragionando da un pò e non capisco, come il babbo di Amelie col nano viaggiatore: non capisco, proprio non capisco.
Non so se sia un racconto metaforico o una pura e semplice apocalisse zombi, però la lettura è divertente.
Tra l'altro la lettura mi ha fatto pensare ai sempre più difficili rapporti tra uomini e donne. Non so, sarà l'effetto Barbie(che io non ho visto) ma in giro sui social è tutto un proliferare di articoli e discussioni sul patriarcato, sul maschilismo, con le posizioni contrapposte che non fanno nessuna una bella figura, con battute da caserma da una parte e ideologie estremiste e intransigenti che troncano sul nascere qualsiasi mediazione dall'altra. La sensazione è che lo scontro ideologico diventerà sempre più aspro, senza potere arrivare a una sintesi.
Comunque, tornando al tuo racconto, la cosa che più mi è piaciuta sono i dialoghi, sinceri, senza cercare sensazionalismi. Seppur diversissimo il racconto, per una sorta di incomunicabilità di fondo, mi ha ricordato la storia di un altro step, dove protagonisti erano due archeologhi o qualcosa del genere.
Incomunicabilità tra i due sessi, o difficoltà nella comunicazione tra i due sessi, questo mi pare il tema del racconto, messo all'interno di una situazione estrema.
Ciò che mi lascia perplesso è il finale: perché non ci sono? Dove sono finiti? Perché non si trovano neppure i resti? Ci sto ragionando da un pò e non capisco, come il babbo di Amelie col nano viaggiatore: non capisco, proprio non capisco.
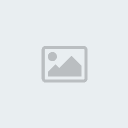
Byron.RN- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 984
Punti : 1075
Infamia o lode : 6
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 49
Località : Rimini
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Un racconto che insiste sulle parole, che scioglie la lingua, che ha il ritmo di una canzone e frasi che sembrano versi.
Dico la mia sul finale. Secondo me è come Lost. In quel garage non ci sono mai arrivati. Sono morti prima. Ma quattro mura e una lampadina appesa sono abbastanza per raccontare la storia di quello che avrebbero potuto essere, usare il loro passato per determinare un presente che non c'è e un futuro che non ci sarà mai. Le loro tracce sono talmente intense che un po' trasudano dal muro che separa l'immaginazione dalla realtà, abbastanza perché i rilevatori sul finale le percepiscano. Boh, magari sto dicendo stupidaggini.
La stanza c'è, anche se il racconto insiste più su altre cose: la canzone, la fine del mondo, l'idea che quando siamo vicini alla fine non ci sia più niente da nascondere ma allo stesso sia così difficile tirare fuori la verità comunque.
Devo dire che mi è piaciuto. Prima di tutto è scritto davvero bene. Ha un'andatura che ti si pianta come un chiodo nel cervello. Mi è piaciuto per come è scritto, più che per la storia che racconta. Ma credo che nell'intenzioni dell'autore ci fosse più quella di lavorare sulle sonorità piuttosto che scavare in profondità nei personaggi o renderli diversi da chiunque altro, tridimensionali.
In ogni caso un buonissimo lavoro.
Dico la mia sul finale. Secondo me è come Lost. In quel garage non ci sono mai arrivati. Sono morti prima. Ma quattro mura e una lampadina appesa sono abbastanza per raccontare la storia di quello che avrebbero potuto essere, usare il loro passato per determinare un presente che non c'è e un futuro che non ci sarà mai. Le loro tracce sono talmente intense che un po' trasudano dal muro che separa l'immaginazione dalla realtà, abbastanza perché i rilevatori sul finale le percepiscano. Boh, magari sto dicendo stupidaggini.
La stanza c'è, anche se il racconto insiste più su altre cose: la canzone, la fine del mondo, l'idea che quando siamo vicini alla fine non ci sia più niente da nascondere ma allo stesso sia così difficile tirare fuori la verità comunque.
Devo dire che mi è piaciuto. Prima di tutto è scritto davvero bene. Ha un'andatura che ti si pianta come un chiodo nel cervello. Mi è piaciuto per come è scritto, più che per la storia che racconta. Ma credo che nell'intenzioni dell'autore ci fosse più quella di lavorare sulle sonorità piuttosto che scavare in profondità nei personaggi o renderli diversi da chiunque altro, tridimensionali.
In ogni caso un buonissimo lavoro.
______________________________________________________


Asbottino- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 542
Punti : 586
Infamia o lode : 0
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 48
Località : Torino
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
devo onestamente ammettere che non sono in grado di dire se non l'ho capito o se non mi piace.
forse tutte e due le cose insieme.
il testo è scorrevole, tutto dialogo o quasi, ma è fortemente ripetitivo e diviene ossessionante, perlomeno ai miei occhi.
ci sono anche svariate incongruenze. c'er la moto e poi non c'è più, c'erano tre pareti o quattro?
certo, sono particolari minimi, ma messi insieme creano confusione.
mi spiace, da parte mia pollice verso.
forse tutte e due le cose insieme.
il testo è scorrevole, tutto dialogo o quasi, ma è fortemente ripetitivo e diviene ossessionante, perlomeno ai miei occhi.
ci sono anche svariate incongruenze. c'er la moto e poi non c'è più, c'erano tre pareti o quattro?
certo, sono particolari minimi, ma messi insieme creano confusione.
mi spiace, da parte mia pollice verso.
______________________________________________________
L'unico modo per non rimpiangere il passato e non pensare al futuro è vivere il presente


Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte.
Kahlil Gibran
Kahlil Gibran

Arunachala- Admin

- Messaggi : 1338
Punti : 1566
Infamia o lode : 16
Data di iscrizione : 20.10.20
Età : 67
Località : Lago di Garda
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Ecco come deve essere condotto un racconto! Un romanzo scritto così, con quel tono, quella lirica, quella trama avrebbe scocciato ma per un racconto è tutto ben distribuito, congegnato, scritto. Di film (più che libri) di amori catastrofici in tempi di pandemia ce ne sono molti (ne ricordo uno molto bello, coreano) ma l'averlo ambientato è la trovata davvero intelligente. Ambiente piccolo, intimo, dove si riflette ancor prima di avere paura. Non è un luogo casuale: è il posto più vicino alla strada quando si vuole fuggire da qualcosa. Quindi paletto centrato in pieno, nonostante tutto. Non ho capito benissimo il finale, ad essere sincero, sarà per la mia scarsità di romanticismo e la mia immaginazione carente. Però promosso in pieno!
Nellone- Younglings

- Messaggi : 146
Punti : 163
Infamia o lode : 1
Data di iscrizione : 26.10.21
Località : Legnano
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Lo confesso: dopo avere finito il racconto sono andata a leggermi i commenti precedenti, perché ero curiosa di vedere cosa era saltato fuori.
Intanto, per quanto riguarda le citazioni. Io, come già ho più volte detto in passato, sono musicalmente molto ignorante. Solo quando nel racconto si fa quindi esplicito riferimento a una canzone, sono andata a cercarla, e ho trovato “Amami” di Emma.
Però qualcuno invece ha tirato fuori Jovanotti, allora eccomi qua ad ascoltare “Ora”. Poi invece ho scoperto che esiste anche una canzone “Amami” di Jovanotti, ed eccomi ad ascoltare anche quella. Insomma, questo racconto ha ampliato la mia cultura musicale di tre canzoni.
Chiaramente, la più usata è la terza, citata in modo ampio ed esplicito, però ci vedo qualcosa anche delle altre due.
Che hanno fatto corto circuito con la passione per le belle donne, per le belle auto (la Honda nel garage) e per l’horror (la pandemia zombie).
Ne è venuta fuori una singolare dichiarazione d’amore. Un amore che esiste e brucia nonostante i difetti esplicitamente dichiarati dei due. Molto, molto carino.
Nota a margine. Tu dici “alta come un barattolo”. Mio marito, per me usa “alta un metro e un tappo” oppure “slanciata verso il basso”. Quando ero giovane, ero la “fidanzata tascabile”. E ho anche la vocetta stridula (purtroppo, però, non sono figa, anzi).
Digito poi ha scovato Erasmo da Rotterdam, ma quello andrò a leggerlo in un altro momento, quando avrò più tempo.
Racconto d’amore/horror o surreale?
Non so, forse tutti e tre. Il punto che mi ha lasciato più dubbi è stato, chiaramente, il finale. Ho l’impressione che tu debba avere seminato qualche indizio per capirlo, ma io non li ho colti.
Dato che la lampadina è bruciata, mi è solo venuto da pensare che debba essere passato tantissimo tempo, quindi, non so, qualcosa che c’entri anche con i viaggi nel tempo? A un certo punto, lei dice che lui è “come un buco nero, perché assorbe tutta la luce degli altri”. Sarà perché ho appena letto un altro racconto dello step in cui si parla di un buco nero, ma non sarà che qui il fantascientifico/surreale è andato in questo senso, per cui i due sono scappati, “andati oltre”, usando le alterazioni del tempo legate alle teorie sui buchi neri?
Ma probabilmente sto ipotizzando sciocchezze, e magari ha ragione Asbottino, che i due nel garage non ci sono mai arrivati.
Quella che invece trovo proprio un po’ una illogicità interna è il fatto che ci sia una pandemia terribile in corso, che si corra il rischio non solo di essere contagiati ma di essere divorati (cosa che proprio simpatica non è) e la gente invece vada tranquillamente in giro a fare cose come andare nei pub o in palestra.
Comunque, credo che faccia tutto un po’ parte del clima surreale che hai creato.
Il racconto è scritto bene. Forse hai calcato troppo sul lato ritmico della scrittura, perché a volte ho percepito l’effetto anaforico come eccessivo (e dire che io ne uso, di anafore).
Confesso che, come altre volte ho detto, questi dialoghi “lui-lei” non sono la mia passione, quindi sinceramente sono la parte che mi è piaciuta meno.
Nel complesso, però, proprio forse anche per gli aspetti un po’ surreal-particolari, il tuo racconto è stato una piacevole lettura.
Arianna 2016- Maestro Jedi

- Messaggi : 1095
Punti : 1153
Infamia o lode : 7
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 54
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Ciao, penna. Più che un racconto è un’ondata di emozioni. Alcuni passaggi sono molto poetici, è forte il senso di angoscia, l’incessante caduta del tempo verso un’ancora più angosciante fine. Ma ancora una volta l’amore viene a salvare i due amanti. Sono senza speranza le battute finali, di umano non è rimasto nulla, nessuna traccia è stata rilevata di un contatto, di una presenza.
Un testo difficile e coraggioso, a tratti incomprensibile, ma forse proprio per questo ha fascino e mistero.
Rileggendo la fine, però, ho interpretato in chiave positiva e cioè che, sebbene il rivelatore umano li abbia segnalati, l’operatore decide di risparmiarli.
Non so, questa è la mia interpretazione perché è più forte il desiderio che riescano a sopravvivere.
Assurdo, complicato, forse contorto, ma a me il tuo racconto è piaciuto.
Un testo difficile e coraggioso, a tratti incomprensibile, ma forse proprio per questo ha fascino e mistero.
Rileggendo la fine, però, ho interpretato in chiave positiva e cioè che, sebbene il rivelatore umano li abbia segnalati, l’operatore decide di risparmiarli.
Non so, questa è la mia interpretazione perché è più forte il desiderio che riescano a sopravvivere.
Assurdo, complicato, forse contorto, ma a me il tuo racconto è piaciuto.

Resdei- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 998
Punti : 1071
Infamia o lode : 4
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 60
Località : Roma
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Parto dal finale, così a caso. Appoggio in parte la.teoria di Asbo (in quel garage non ci sono mai entrati, sono morti prima) ma l'accenno al buco nero mi fa pensare agli universi paralleli. Quindi erano nel garage, ma amandosi attraversano un buco nero e vanno in un posto sicuro (o magari anche meno sicuro, chi lo sa).
Mi piace molto come hai gestito la storia. Ha un tocco poetico, e le storie che hanno uno sfondo "horror-apocalittico" ma vengono gestite con un registro narrativo non convenzionale mi conquistano sempre.
Qui non succede granché, sono rinchiusi, emergono dinamiche di amore odio tra i due, pianti isterici e tutto molto molto coerente con la situazione paradossale che stanno vivendo.
Mi piace questo storia e mi piace il tuo garage che salva chi si ama.
Piaciuto.
Ele
Mi piace molto come hai gestito la storia. Ha un tocco poetico, e le storie che hanno uno sfondo "horror-apocalittico" ma vengono gestite con un registro narrativo non convenzionale mi conquistano sempre.
Qui non succede granché, sono rinchiusi, emergono dinamiche di amore odio tra i due, pianti isterici e tutto molto molto coerente con la situazione paradossale che stanno vivendo.
Mi piace questo storia e mi piace il tuo garage che salva chi si ama.
Piaciuto.
Ele

Hellionor- Admin

- Messaggi : 757
Punti : 813
Infamia o lode : 10
Data di iscrizione : 17.10.20
Età : 44
Località : torino
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Mi piace e non mi piace, autore, che nella tua storia ci siano diverse spiegazioni più o meno plausibili, soprattutto per il finale.
Nel garage ci sono arrivati o non ci sono arrivati? Il loro amore, dalle premesse quasi impossibili, si concretizza o è tutto fantasia?
Non sono riuscito a trovare indizi inequivocabili, ma magari sbaglio io.
Mi piace l'ambientazione da apocalisse zombie, con diversi cliché del caso, ma penso che quest'ultima sia più che altro un pretesto, una scusa, per dare un background alla tua storia, data la scarsità di dettagli che emergono sulla pandemia in corso. Non che siano fondamentali, in ogni caso.
La canzone di Jovanotti è stata una buffa sorpresa. Di solito non sono un fan delle canzoni inserite nei racconti, perché un conto è ascoltarle e un conto è leggerle, ma qui tutto sommato la commistione funziona, e non si nota più di tanto la distanza di registro.
Non ho solo ben capito se l'una è al servizio dell'altro o viceversa.
Complessivamente il racconto funziona, perlomeno per lo scambio reiterato di battute. Il finale, forse volutamente aperto, invece, mi lascia un senso di incompiutezza, che non so decidere se per mio difetto d'interpretazione o meno.
Nel garage ci sono arrivati o non ci sono arrivati? Il loro amore, dalle premesse quasi impossibili, si concretizza o è tutto fantasia?
Non sono riuscito a trovare indizi inequivocabili, ma magari sbaglio io.
Mi piace l'ambientazione da apocalisse zombie, con diversi cliché del caso, ma penso che quest'ultima sia più che altro un pretesto, una scusa, per dare un background alla tua storia, data la scarsità di dettagli che emergono sulla pandemia in corso. Non che siano fondamentali, in ogni caso.
La canzone di Jovanotti è stata una buffa sorpresa. Di solito non sono un fan delle canzoni inserite nei racconti, perché un conto è ascoltarle e un conto è leggerle, ma qui tutto sommato la commistione funziona, e non si nota più di tanto la distanza di registro.
Non ho solo ben capito se l'una è al servizio dell'altro o viceversa.
Complessivamente il racconto funziona, perlomeno per lo scambio reiterato di battute. Il finale, forse volutamente aperto, invece, mi lascia un senso di incompiutezza, che non so decidere se per mio difetto d'interpretazione o meno.

Fante Scelto- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 768
Punti : 912
Infamia o lode : 0
Data di iscrizione : 08.01.21
Località : Torino
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Dato che sono state fatte delle domande nei commenti e che l'autore non può rispondere dico la mia.
@Petunia @Arunachala la Honda può essere anche una macchina.
@ImaGiraffe c'è un libro di Stephen King che s'intitola Buick 8 (tra l'altro tra i meno riusciti, che ne dici @Byron.RN?) dove la gente entra e scompare e allo stesso tempo arrivano "cose" da un altro mondo. Credo che nel racconto che abbiamo letto i protagonisti siano andati semplicemente via, come la bambina in Cent'anni di solitudine che a un certo punto viene assunta in cielo e se ne va.
Non c'è un vero e proprio perchè e non c'è una spiegazione, accade e basta.
Sono tutte mie supposizioni, eh.
L'invasione zombi credo sia una cosa iniziata all'improvviso quella sera stessa (e qui tiro in ballo Cell (autore credo tu sia un fan di King...): prima la gente andava in palestra, al pub, poi puf, tutto finito nel giro di poche ore.
A questo proposito credo, in generale, che l'autore voglia sottolineare un urgenza, voglia dire che davvero abbiamo poco tempo e, anche se nessuno ne è convinto davvero, un giorno moriremo e non ci sarà più tempo per niente.
E allora basta girarci intorno: diciamoci le cose in faccia, non rimandiamo.
Il racconto è molto carico, il ritmo martellante, la situazione stressante: eppure per i due è comunque difficile aprirsi, dirsi la verità. Però ce la fanno, a tentativi, in modo sgangherato, ma riescono a dirsi ciò che veramente pensano l'uno dell'altro ( e in un mondo finto come il nostro è un bel passo avanti).
Poi si amano in un modo nuovo, scevro dalla falsità, liberi, finalmente se stessi.
E poi scompaiono, forse perchè un amore così puro non deve essere visto.
Non so autore, ma il ritmo del tuo racconto, la difficoltà di aprirsi descritta così bene, mi hanno ispirato queste riflessioni.
I dialoghi rappresentano bene la situazione: c'è poco tempo, c'è l'urgenza di chiarirsi e spiegarsi, tutto però senza sapere come fare. Quando l'argine delle convenzione si rompe vengono investiti dai loro veri pensieri rimanendone scossi ma al tempo stesso gratificati: non so, ma c'è qualcosa che mi ha convinta nel loro modo di dirsi le cose così aggressivo, sbagliato e diretto ma in definitiva vero.
Non conoscevo la canzone (o le canzoni, non ho ben capito...) che hai inserito. Alla seconda lettura le ho proprio saltate: il testo funziona lo stesso e anzi, l'ho percepito più leggero e gradevole. Non mi è mai piaciuto leggere i testi delle canzoni: zoppicano, gli manca qualcosa, non sono fatti per essere letti, ma cantati.
@Petunia @Arunachala la Honda può essere anche una macchina.
@ImaGiraffe c'è un libro di Stephen King che s'intitola Buick 8 (tra l'altro tra i meno riusciti, che ne dici @Byron.RN?) dove la gente entra e scompare e allo stesso tempo arrivano "cose" da un altro mondo. Credo che nel racconto che abbiamo letto i protagonisti siano andati semplicemente via, come la bambina in Cent'anni di solitudine che a un certo punto viene assunta in cielo e se ne va.
Non c'è un vero e proprio perchè e non c'è una spiegazione, accade e basta.
Sono tutte mie supposizioni, eh.
L'invasione zombi credo sia una cosa iniziata all'improvviso quella sera stessa (e qui tiro in ballo Cell (autore credo tu sia un fan di King...): prima la gente andava in palestra, al pub, poi puf, tutto finito nel giro di poche ore.
A questo proposito credo, in generale, che l'autore voglia sottolineare un urgenza, voglia dire che davvero abbiamo poco tempo e, anche se nessuno ne è convinto davvero, un giorno moriremo e non ci sarà più tempo per niente.
E allora basta girarci intorno: diciamoci le cose in faccia, non rimandiamo.
Il racconto è molto carico, il ritmo martellante, la situazione stressante: eppure per i due è comunque difficile aprirsi, dirsi la verità. Però ce la fanno, a tentativi, in modo sgangherato, ma riescono a dirsi ciò che veramente pensano l'uno dell'altro ( e in un mondo finto come il nostro è un bel passo avanti).
Poi si amano in un modo nuovo, scevro dalla falsità, liberi, finalmente se stessi.
E poi scompaiono, forse perchè un amore così puro non deve essere visto.
Non so autore, ma il ritmo del tuo racconto, la difficoltà di aprirsi descritta così bene, mi hanno ispirato queste riflessioni.
I dialoghi rappresentano bene la situazione: c'è poco tempo, c'è l'urgenza di chiarirsi e spiegarsi, tutto però senza sapere come fare. Quando l'argine delle convenzione si rompe vengono investiti dai loro veri pensieri rimanendone scossi ma al tempo stesso gratificati: non so, ma c'è qualcosa che mi ha convinta nel loro modo di dirsi le cose così aggressivo, sbagliato e diretto ma in definitiva vero.
Non conoscevo la canzone (o le canzoni, non ho ben capito...) che hai inserito. Alla seconda lettura le ho proprio saltate: il testo funziona lo stesso e anzi, l'ho percepito più leggero e gradevole. Non mi è mai piaciuto leggere i testi delle canzoni: zoppicano, gli manca qualcosa, non sono fatti per essere letti, ma cantati.

caipiroska- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 864
Punti : 919
Infamia o lode : 7
Data di iscrizione : 07.01.21
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
@caipiroska è vero, hai ragione. Credo che Buick 8 sia uno dei suoi libri peggiori, assieme a Cell. Anche se, il libro che mi è piaciuto di meno in assoluto è La metà oscura. Perdonate le nostre divagazioni kinghiane.
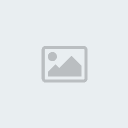
Byron.RN- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 984
Punti : 1075
Infamia o lode : 6
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 49
Località : Rimini
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Dopo averlo riletto , dopo aver scandagliato tutti i commenti, tutte le emozioni indotte, ho capito il valore di questo racconto. Grazie per averlo proposto, autore. Anche se adesso mi sento piccolo piccolo, come un pulcino.
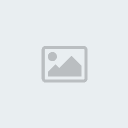
tommybe- Maestro Jedi

- Messaggi : 1233
Punti : 1334
Infamia o lode : 19
Data di iscrizione : 18.11.21
Età : 72
Località : Roma
 Re: Elogio delle ore (Amami)
Re: Elogio delle ore (Amami)
Si legge tutto d'un fiato, ti avvince, ti fa immedesimare nell'uno o nell'altra. Ti fa ricordare momenti di solitudine e di isolamento che, chi più chi meno, tutti abbiamo provato a causa del COVID. Poi il finale ti sconvolge. Notevole!
______________________________________________________
Come l'acqua che scorre, sono un viandante in cerca del mare. Z. M.

Menico- Padawan

- Messaggi : 190
Punti : 208
Infamia o lode : 0
Data di iscrizione : 11.02.22
Pagina 1 di 2 • 1, 2 
 Argomenti simili
Argomenti simili» Aida delle Nuvole
» La fine delle biblioteche
» Il gioco delle nuvole
» Il ponte delle catene
» Il cielo delle cento stagioni
» La fine delle biblioteche
» Il gioco delle nuvole
» Il ponte delle catene
» Il cielo delle cento stagioni
Different Tales :: Off Topic :: Archivio :: Different Rooms - Tutti i racconti :: Step 13 - L'autorimessa
Pagina 1 di 2
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.|
|
|

» La prossima scossa
» Mentre tutto brucia
» Routine
» La porta rossa
» Il cronovisore del tempo
» Autodistruttivo
» Last Horizon
» Cronache dalla fine