Bum Bum Bum
+3
Susanna
Petunia
The Raven
7 partecipanti
Pagina 1 di 1
 Bum Bum Bum
Bum Bum Bum
- Spoiler:
Sento i loro colpi giù al piano di sotto.
Sono nascosto in soffitta, non mi troveranno facilmente.
La puzza di muffa mi soffoca, ma dopo un po’ il naso si abitua e quel tanfo non pare neanche troppo nauseabondo.
Bum, bum, bum.
Certo che colpiscono proprio forte.
Ogni colpo sferzato fa tremare le pareti e i vetri dei lucernai di questa mansarda che ormai è diventata la mia prigione.
L’affitto da pagare a fine mese e il lavoro che manca.
Da ormai sette – quasi otto – mesi sono a casa.
Ho sempre fatto le cose per bene: un prestigioso liceo scientifico di città, un gran bel centodiecielode in ingegneria informatica.
Avevo dei sogni: mi vedevo in una grande azienda, col camice bianco, a sbocchinare su macchine e circuiti super-tecnologici. Avevo appena compiuto venticinque anni, ero un neo-laureato e ogni santo giorno andavo in giro per ogni provincia della mia regione a consegnare curriculum vitae e fare colloqui di lavoro.
Tutte le volte la solfa era il solito le faremo sapere.
Svaniva intanto la passione, scompariva l’entusiasmo e subentrava quel senso di frustrazione che da quel momento mi avrebbe accompagnato per almeno una ventina d’anni.
Era passato più di un anno, nessun impiego soddisfacente era arrivato.
I miei genitori erano diventati insofferenti e non condividevano più i miei rifiuti agli impieghi che mi venivano proposti.
Tristemente accettai l’ennesima offerta e quell’ingegnere che ero si era ritrovato allo sportello di una filiale dell’Enel a risolvere i problemi di utenti arrabbiati e morosi.
Era pur sempre un posto fisso, stavo seduto a una scrivania, ero pagato anche bene (un milione e due al mese) e l’ambiente non era poi male, dato che il caffè e persino i cornetti alla mattina venivano offerti dall’azienda.
Il mio posto era sempre lo stesso: sportello numero due.
Al numero uno sedeva Gianni e al tre Annalisa. Era sempre carina, mi portava il caffè, mi sorrideva e mi riempiva di attenzioni.
Infatti le chiesi di uscire.
Il primo appuntamento fu imbarazzante: io ero impacciato, sembravo un quattordicenne emozionato.
Lei aveva un abito rosso di percalle che la rendeva una diva del cinema americano degli anni di Hitchcock, una Grace Kelly dai capelli castani.
Io, fasciato nel mio maglione smanicato e camicia, non potevo far altro che contemplarla. Mangiammo in quel ristorantino giapponese, non senza le difficoltà e le prese in giro dovute all’uso delle bacchette. Quella sera la baciai.
Un anno dopo avevamo fatto il grande passo: non il matrimonio – quello sarebbe arrivato dopo altri sei mesi – ma l’accensione di quel mutuo trentennale per l’acquisto di una villetta su più piani con mansarda e cantinetta.
Io e Annalisa ci godevamo giorno dopo giorno la nostra alcova; il mutuo era gravoso, ma con due stipendi si viveva abbastanza tranquillamente.
L’amore c’era, da parte di entrambi, e si faceva pure; e fu così che in un sol colpo arrivarono Giulia e Grazia, due bellissime gemelline. Insomma, eravamo una famigliola felice.
Non sbocchinavo coi circuiti super-tecnologici ma ero felice. Nonostante mi fossi accontentato di quel lavoro, io ero un uomo felice.
La situazione economica ormai non mi preoccupava più: quindici anni di mutuo erano già pagati e l’Enel era un’azienda seria e solida.
Ogni estate si andava in campeggio.
La settimana di ferragosto era quella che preferivamo. Si andava sempre nello stesso villaggio turistico, la routine era sempre la stessa: risveglio muscolare alle nove, poi giochi con le bambine in spiaggia, riposino dopo pranzo, balli di gruppo al pomeriggio e a ballare la sera dopo cena.
Anche le bimbe si divertivano.
Come la nostra, anche altre famiglie venivano ogni anno nello stesso campeggio: c’eravamo fatti degli amici.
Poi la grande crisi di inizio millennio. Tre sportelli, nella nostra piccola cittadina, erano diventati troppi.
L’incubo dei tagli aleggiava sulle nostre teste. Assistemmo alla diminuzione delle scrivanie degli uffici del primo e del secondo piano (il terzo piano, quello più alto, non era stato naturalmente toccato). E anche gli sportelli dedicati al pubblico furono tagliati: da tre diventarono due.
Gianni aveva famiglia, quindi venne licenziata Annalisa che, con non poca disapprovazione e preoccupazione per il mutuo, diventò casalinga a tempo pieno.
Stringemmo la cinghia; il mutuo portava via più di metà del mio unico stipendio, le bambine avevano bisogno di libri, penne, quaderni e diari e la spesa costava.
Ma riuscimmo a tirare avanti.
Annalisa provò a lavorare part time in un call center, ma lo stress era troppo e la paga troppo misera.
Un anno e poi licenziarono anche me. Il capo mi chiamò nel suo ufficio al terzo piano e mi comunicò che anche gli sportelli numero uno e due avrebbero chiuso. Gli utenti che avessero avuto bisogno avrebbero utilizzato il numero verde, che ancora oggi risponde solo per tre ore ogni mattina.
Anche io mi ritrovai a casa, senza lavoro, a quarantatre anni.
Mi sentivo come diciotto anni prima, ero di nuovo un ingegnere alla ricerca di un lavoro. Ma stavolta era ancora peggio. Nessuno voleva uno della mia età.
Così mi lasciai andare, cominciai a bere e a passare le mie giornate davanti alla televisione, sul divano in salotto.
Praticamente non uscivo più di casa, guardavo gli annunci di lavoro dal computer e mandavo sempre meno curriculum. La vodka liscia era diventata la mia compagna preferita da quando ero da solo in casa. Annalisa prestava servizio come badante a ore da una vecchia rincoglionita e scorbutica e io mi ubriacavo sul sofà.
Litigavamo davvero tanto, io e Annalisa. Non facevamo più neanche l’amore.
La vodka mi faceva dormire un sacco e lei era stanca di ripetermi che non aveva più intenzione di stare con uno scansafatiche che non lavorava e che non faceva altro che bere dalla mattina alla sera.
La sentivo piangere in bagno tante volte; un po’ mi dispiacevo, ma ormai i miei sentimenti e le mie emozioni erano annebbiate, proprio come la mia mente ubriaca.
Il momento tanto temuto è arrivato.
Annalisa ha deciso di lasciarmi e di tornare da sua madre.
Il litigio è davvero furibondo stavolta: mi urla di non volere che le sue figlie crescano con un esempio di padre del genere.
Stavolta sono io a piangere, la imploro di non fare cose avventate, che posso cambiare e che voglio riprendere in mano la mia vita, ché lei sa quanto valgo.
Ma le sue intenzioni sono ferme e le mie preghiere vane.
La mia disperazione non riesce a scalfirla stavolta: è decisa e vuole andare via, portandosi tutta la mia vita.
Non posso permetterlo, non posso permetterle di rovinare tutto.
Le ragazze danno ragione alla mamma, dicono che hanno paura di me.
La rabbia monta, riempie gli occhi e li infiamma.
Le urla sono laceranti.
In questa mattina d’inverno ho ammazzato mia moglie e le mie due figlie con un coltello da cucina.
Le sto guardando. Eccole, sono lì, riverse sul pavimento del salotto.
Non provo nulla, non provo dolore nel guardarle, solo ribrezzo.
Non riesco a guardare quei cadaveri senza vomitare.
Dopo aver rimesso sul tappeto, corro e mi nascondo in soffitta.
Sicuramente saranno stati i vicini a chiamare i carabinieri. Il frastuono deve averli allarmati.
E adesso sono alla porta. È una porta blindata, spessa.
Bum, bum. Bum.
Stanno cercando di sfondarla con un ariete, ma deve proprio essere un uscio resistente: sarà almeno un minuto che quel rumore cadenzato e regolare mi martella le tempie, che mi stanno esplodendo.
“Potranno sfondare tutte le porte del mondo coi loro arieti, ma non sapranno mai cosa è successo in questa casa stasera, non potranno penetrare anche nella mia testa, non sapranno mai niente di quello che è successo” penso.
A un tratto i colpi cessano. Sento il loro sgomento alla scena che si son trovati davanti appena entrati. Mi cercano, in ogni stanza. Sono in tanti, sento confusione al piano inferiore.
Alla fine capiscono, arrivano in soffitta.
Non è facile sfondarla, mi sono barricato dentro. Ecco che ritornano i colpi dell’ariete: bum bum bum.
La sfonderanno senza troppi problemi, stavolta.
E lì mi troveranno.
La lama che ha ucciso mia moglie e le mie due figlie sarà conficcata nel mio petto.
______________________________________________________
IN GRAN SILENZIO OGNI PARTIGIANO GUARDAVA QUEL BASTONE SU IN COLLINA.
REACH OUT AND TOUCH FAITH! Sembrano di sognante demoni gli occhi, e i rai
del lume ognor disegnano l’ombra sul pavimento,
né l’alma da quell’ombra lunga sul pavimento
sarà libera mai!
Quel vizio che ti ucciderà
non sarà fumare o bere,
ma è qualcosa che ti porti dentro,
cioè vivere.

The Raven- Admin

- Messaggi : 862
Punti : 1047
Infamia o lode : 28
Data di iscrizione : 18.10.20
Età : 36
Località : Cesena
 Re: Bum Bum Bum
Re: Bum Bum Bum
O mamma @The Raven… se ancora sonnecchiavo mi sono svegliata di brutto!
Un racconto potente, scritto in modo magnifico. Prima di tutto il ritmo. Un bolero che ti cattura fin dalle prime note e ti conduce in un crescendo verso il climax. Non si riesce a smettere di leggere, non ci sono distrazioni. Si arriva a empatizzare col protagonista, quasi a comprendere l’insano gesto (che botta)
Nella sua crudezza, resa ancor più vivida dal fatto che tragedie simili non sono frutto di fantasia, non c’è di mezzo il sopra naturale, un demone, una malattia mentale, la storia è frutto dei nostri tempi.
In queste poche righe metti in campo moltissimo e lo fai davvero bene.
Una bella rivisitazione del “cuore rivelatore” del Maestro Poe.
Complimenti e grazie per la condivisione.
Un racconto potente, scritto in modo magnifico. Prima di tutto il ritmo. Un bolero che ti cattura fin dalle prime note e ti conduce in un crescendo verso il climax. Non si riesce a smettere di leggere, non ci sono distrazioni. Si arriva a empatizzare col protagonista, quasi a comprendere l’insano gesto (che botta)
Nella sua crudezza, resa ancor più vivida dal fatto che tragedie simili non sono frutto di fantasia, non c’è di mezzo il sopra naturale, un demone, una malattia mentale, la storia è frutto dei nostri tempi.
In queste poche righe metti in campo moltissimo e lo fai davvero bene.
Una bella rivisitazione del “cuore rivelatore” del Maestro Poe.
Complimenti e grazie per la condivisione.

Petunia- Moderatore

- Messaggi : 2311
Punti : 2548
Infamia o lode : 43
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 60
Località : Prato
 Re: Bum Bum Bum
Re: Bum Bum Bum
Dopo un periodo di rallenty dalle lettura over step, anzi dai commenti over step, volevo cercare autori di cui ho letto ancora poco e mi imbatto in questo racconto che... mamma mia, a parte la tristissima attualità, tiene il lettore fin dalle prime righe. Quando le cose vanno troppo bene, è inevitabile che prima o poi virino da un'altra parte. Storie come questa ne troviamo quasi ogni giorno sui giornali, fanno male perchè ad esserne coinvolte sono persone come noi, che arrivate ad un certo punto non ce la fanno più.
In tanti tacciano i protagonisti di queste storie come deboli, incapaci di reagire, inetti e chi ne ha più ne metta: vengono anche distribuite colpe verso chi non ha teso (ancora una volta) una mano, verso chi avrebbe potuto aiutarli ma non l'ha fatto. I problemi sono sempre degli altri, ma se ti ci ritrovi in mezzo... il timore di un fallimento sbandierato ai quattro venti, il non poter mantenere lo stesso tenore di vita, essere visto come esempio negativo per i figli... non mettetevi da una sola parte. Voi cosa fareste al posto di questa persona? Siete di sicuri di trovare soluzioni immediate? Di avere agganci che al momento buono non ti voltano le spalle? E' un racconto, caro @theraven, che fa male. Molto male.
Che poi sia scritto davvero bene, un lessico semplice ed essenziale,che aiuta sicuramente ad entrare nella storia, con un ritmo che tiene fin dalla prima riga, che instauri col lettore un patto di "non abbandonare la lettura anche se immagini il finale" non ci piove, ma fa male.
Però ti dico: bravo.
In tanti tacciano i protagonisti di queste storie come deboli, incapaci di reagire, inetti e chi ne ha più ne metta: vengono anche distribuite colpe verso chi non ha teso (ancora una volta) una mano, verso chi avrebbe potuto aiutarli ma non l'ha fatto. I problemi sono sempre degli altri, ma se ti ci ritrovi in mezzo... il timore di un fallimento sbandierato ai quattro venti, il non poter mantenere lo stesso tenore di vita, essere visto come esempio negativo per i figli... non mettetevi da una sola parte. Voi cosa fareste al posto di questa persona? Siete di sicuri di trovare soluzioni immediate? Di avere agganci che al momento buono non ti voltano le spalle? E' un racconto, caro @theraven, che fa male. Molto male.
Che poi sia scritto davvero bene, un lessico semplice ed essenziale,che aiuta sicuramente ad entrare nella storia, con un ritmo che tiene fin dalla prima riga, che instauri col lettore un patto di "non abbandonare la lettura anche se immagini il finale" non ci piove, ma fa male.
Però ti dico: bravo.
______________________________________________________
"Quindi sappiatelo, e consideratemi pure presuntuoso, ma io non scrivo per voi. Scrivo per me e, al limite, per un'altra persona che può capire. Spero di conoscerla un giorno… G. Laquaniti"
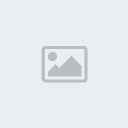
Susanna- Maestro Jedi

- Messaggi : 2344
Punti : 2585
Infamia o lode : 20
Data di iscrizione : 03.02.21
Età : 67
Località : Rumo (TN)
 Re: Bum Bum Bum
Re: Bum Bum Bum
Solo un piccolo appunto, e te lo segnalo subito così poi passiamo alle cose importanti: a inizio racconto scrivi "L’affitto da pagare a fine mese e il lavoro che manca.
Da ormai sette – quasi otto – mesi sono a casa."
ma invece non pagano l'affitto, hanno un mutuo. correggere, su su su.
Pezzo disturbante, ben condotto dall'inizio alla fine, anche prima di sapere cosa è accaduto aleggia tra le parole una sensazione di smarrimento e di oppressione, di qualcosa di malato che si sta concretizzando sotto i nostri occhi. Non c'è giudizio ma c'è solo un storia, raccontata dal protagonista e quindi è la sua versione della storia, la versione che si sta raccontando; e infatti l'omicidio è u passaggio veloce del racconto, che è un viaggio di egocentrismo nella vita di un uomo che ha fallito, ma non perché è rimasto senza lavoro e ha ucciso la sua famiglia, ha fallito perché non aveva mai guardato al di là del proprio naso e di se stesso.
Ho apprezzato molto come attraverso le parole lucide e folli del tuo personaggio si leggano tutte le sue psicosi e si compia con lui un viaggio verso l'abisso.
Ele
Da ormai sette – quasi otto – mesi sono a casa."
ma invece non pagano l'affitto, hanno un mutuo. correggere, su su su.
Pezzo disturbante, ben condotto dall'inizio alla fine, anche prima di sapere cosa è accaduto aleggia tra le parole una sensazione di smarrimento e di oppressione, di qualcosa di malato che si sta concretizzando sotto i nostri occhi. Non c'è giudizio ma c'è solo un storia, raccontata dal protagonista e quindi è la sua versione della storia, la versione che si sta raccontando; e infatti l'omicidio è u passaggio veloce del racconto, che è un viaggio di egocentrismo nella vita di un uomo che ha fallito, ma non perché è rimasto senza lavoro e ha ucciso la sua famiglia, ha fallito perché non aveva mai guardato al di là del proprio naso e di se stesso.
Ho apprezzato molto come attraverso le parole lucide e folli del tuo personaggio si leggano tutte le sue psicosi e si compia con lui un viaggio verso l'abisso.
Ele

Hellionor- Admin

- Messaggi : 787
Punti : 846
Infamia o lode : 11
Data di iscrizione : 17.10.20
Età : 44
Località : torino
 Re: Bum Bum Bum
Re: Bum Bum Bum
Nel racconto c'è un uso massiccio di era, ero, erano che ingolfano un po' la lettura: questo è il modo più semplice per costruire le frasi, ma credo che un pizzico d'inventiva in più potrebbe aiutare a rendere il testo più accattivante e interessante.
La storia è raccontata dal protagonista in prima persona: in questo modo viene un po' meno il pathos e si tende a trovare le colpe al di fuori di sè stessi: difficile che chi racconta una storia prenda parte alle responsabilità che lo chiamano in causa; di solito il narratore riversa su cause esterne le colpe senza mai chiamarsi in causa, quando in realtà sono probabilmente la causa stessa del disagio inizia proprio con lui (in Africa hanno molti meno mezzi di noi, in generale, ma trovano lo stesso la forza di andare avanti).
Il racconto è ciclico, finisce dove inizia, nel mezzo la discesa nella disperazione di una famiglia normale, anche se non è mai preponderante la follia che rode l'uomo da dentro. Il gesto finale arriva un po' troppo inaspettato: il lettore non aveva avuto abbastanza avvisaglie sulla sanità mentale compromessa del protagonista e questo twist nella narrazione, a mio avviso, non paga come dovrebbe, perchè togli tutti i brividi al lettore di un disastro imminente (fondamentali in una narrazione che vuole colpire il lettore con atti atroci e inspiegabili).
Riesci comunque a incuriosire e a tenere alta la curiosità per come si evolverà questa triste storia. Manca il supporto della moglie e della famiglia in generale, anzi non vengono affatto indagati i rapporti tra i congiunti: rimane solo il riassunto di una vita fatta solo dalla voce di lui. Ecco, avrei preferito sentire la sua follia, invece c'è solo la sua rassegnazione che non giustifica fino in fondo l'insano gesto.
La storia è raccontata dal protagonista in prima persona: in questo modo viene un po' meno il pathos e si tende a trovare le colpe al di fuori di sè stessi: difficile che chi racconta una storia prenda parte alle responsabilità che lo chiamano in causa; di solito il narratore riversa su cause esterne le colpe senza mai chiamarsi in causa, quando in realtà sono probabilmente la causa stessa del disagio inizia proprio con lui (in Africa hanno molti meno mezzi di noi, in generale, ma trovano lo stesso la forza di andare avanti).
Il racconto è ciclico, finisce dove inizia, nel mezzo la discesa nella disperazione di una famiglia normale, anche se non è mai preponderante la follia che rode l'uomo da dentro. Il gesto finale arriva un po' troppo inaspettato: il lettore non aveva avuto abbastanza avvisaglie sulla sanità mentale compromessa del protagonista e questo twist nella narrazione, a mio avviso, non paga come dovrebbe, perchè togli tutti i brividi al lettore di un disastro imminente (fondamentali in una narrazione che vuole colpire il lettore con atti atroci e inspiegabili).
Riesci comunque a incuriosire e a tenere alta la curiosità per come si evolverà questa triste storia. Manca il supporto della moglie e della famiglia in generale, anzi non vengono affatto indagati i rapporti tra i congiunti: rimane solo il riassunto di una vita fatta solo dalla voce di lui. Ecco, avrei preferito sentire la sua follia, invece c'è solo la sua rassegnazione che non giustifica fino in fondo l'insano gesto.

caipiroska- Cavaliere Jedi

- Messaggi : 892
Punti : 947
Infamia o lode : 7
Data di iscrizione : 07.01.21
 Re: Bum Bum Bum
Re: Bum Bum Bum
Sono d'accordo con chi mi ha preceduto: è un racconto che ti prende alla gola e non ti molla. Dovresti però togliere la frase "L’affitto da pagare a fine mese e il lavoro che manca" per due ragioni. 1. la prima te l'hanno già fatta notare: se ha il mutuo non paga l'affitto e 2. a questo punto del racconto il lettore potrebbe, non senza sorridere, mettere in relazione il fatto che il protagonista si sia nascosto in mansarda, il bussare forte e l'affitto da pagare ed essere portato a pensare che il padrone di casa bussa forte alla porta per riscuotere gli affitti arretrati.

tontonlino- Younglings

- Messaggi : 117
Punti : 137
Infamia o lode : 2
Data di iscrizione : 07.01.21
Età : 69
 Re: Bum Bum Bum
Re: Bum Bum Bum
Prima le cose effimere:
- il racconto è scritto in prima persona da un uomo. Un uomo che sa riconosce il tessuto percalle? (tra l'altro è un tessuto prevalentemente usato per le lenzuola)
- Enel che offre caffè e brioche? Sembra più un'utopia.
Passiamo alle cose serie. Il racconto ha una sua potenza, è scritto bene con un linguaggio scorrevole senza manierismi di sorta. Concordo con Caipiroska nel dire che forse manca un po' di pathos, c'è il ritmo, la frenesia, ma manca un po' l'emozione del protagonista.
Una domanda: perché usi "sbocchinare" così tante volte e scritto in corsivo? Scusami forse non ho colto qualcosa.
A rileggerci
- il racconto è scritto in prima persona da un uomo. Un uomo che sa riconosce il tessuto percalle? (tra l'altro è un tessuto prevalentemente usato per le lenzuola)
- Enel che offre caffè e brioche? Sembra più un'utopia.
Passiamo alle cose serie. Il racconto ha una sua potenza, è scritto bene con un linguaggio scorrevole senza manierismi di sorta. Concordo con Caipiroska nel dire che forse manca un po' di pathos, c'è il ritmo, la frenesia, ma manca un po' l'emozione del protagonista.
Una domanda: perché usi "sbocchinare" così tante volte e scritto in corsivo? Scusami forse non ho colto qualcosa.
A rileggerci

Mac- Padawan

- Messaggi : 369
Punti : 408
Infamia o lode : 1
Data di iscrizione : 09.11.21
Località : Verona
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
» Con il nome giusto
» Quando non tutti gli uccelli avevano il becco
» Libero arbitrio
» Una triste storia d'amore
» Penne, piume e rock and roll
» Nuda vola
» Come degli uccelli, simili agli uccelli
» Il canto dell'aquila